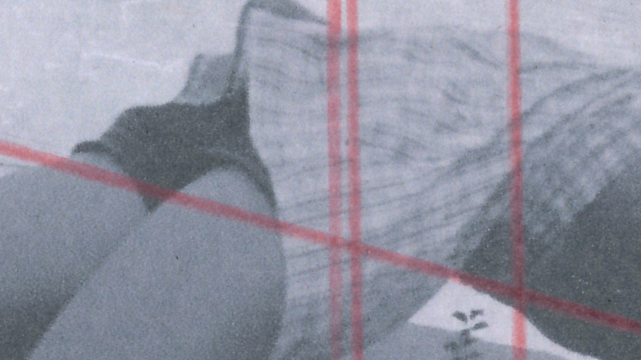MIGRANTESSE
Nel 2012 abbiamo realizzato, per conto della Provincia di Cagliari, un documentario sulla migrazione femminile. Si trattava di un’indagine sul fenomeno in generale basato su interviste a diverse donne di differenti nazionalità residenti nel territorio. Per via della corposità del questionario che proponevamo, abbiamo dovuto dilazionare le interviste e incontrare le donne coinvolte parecchie volte nell’arco di circa 6 mesi di lavoro, e con alcune di loro si sono stabiliti dei rapporti sempre più confidenziali ed amichevoli. Ad un certo punto del progetto si era creato lo spazio per poter realizzare una vecchia idea fotografica che ancora non ero riuscita a realizzare. Si trattava di vestire con il costume sardo (diventato negli ultimi decenni quasi il manifesto di una certa sarditudine folkloristica e autoreferenziale) le donne straniere e di ottenere così un effetto paradossale e provocatorio. L’abito fa davvero il monaco? Noi sardi davvero riconosciamo in questo oggetto-feticcio, in questa immagine folkloristica un significante, una traccia visibile dell’appartenenza essenziale alle nostre tradizioni culturali, nazionali, sociali? E se l’abito è elemento identitario, che cosa può provocare alla nostra pigra percezione vederlo vestito da persone che sono aliene alle nostre tradizioni, ma che con noi condividono la vita, il lavoro, le abitudini, i luoghi, la cadenza della lingua, i cibi, gli umori, i toni? Che insomma si stanno integrando (volenti o nolenti noi e loro) nella nostra realtà. Adesso. In verità si trattava di un’intuizione puramente estetica, una sorta di visione che meritava di essere sperimentata. E accadde qualcosa che non avevamo previsto. Durante la realizzazione di quelle fotografie, ci rendemmo conto che quel che stava accadendo era fortemente significativo non tanto sul piano dell’immagine di per sé stessa, ma sul piano sociale. Ovvero sulla ricaduta che quel tipo di operazione ebbe sulla rete di relazioni che andava incoraggiando. Si trattava di fotografie scattate in case tradizionali, con costumi prestati o da privati o da gruppi folk e di donne migranti. Questi 3 soggetti, coinvolti nello stesso gioco, hanno avuto modo di condividere un’esperienza per tutti insolita e per questo divertente che ha creato le condizioni ideali per intiepidire l’atmosfera e permettere la relazione. La preparazione agli scatti, fatta di corpetti da stringere, gioielli da abbinare, pettinature, caffè e dolcetti ci ha permesso di rilassarci e di stabilire un vero e proprio confronto su temi, modi, civetterie squisitamente femminili praticamente universali. Le differenze di età, estrazione sociale, religione, cultura, ecc. andavano sgretolandosi a mano a mano che il lavoro comune (nella sua piacevolezza anche stancante e che ci impegnava tutte con ruoli definiti) veniva svolto. Le fotografie a quel punto erano state poco più che un pretesto. La visione dell’operazione si era capovolta. Da quell’ esperienza nasce il progetto fotografico MIGRANTESSE, che riparte dalla stessa immagine paradossale e si propone di continuare a indagare però proprio sulla relazione condizionata che avevamo avuto modo di vivere e osservare. Forse però mancava un elemento ulteriore a quel sistema di relazioni. Mancava un argomento. Mancava il coinvolgimento in quel gesto che alla fine ci era sembrato quasi accessorio. Mancava la fotografia. In questa seconda tappa della nostra indagine, ci piacerebbe aggiungere quest’elemento lavorando (attraverso un percorso guidato) proprio sull’oggetto-fotografia, sulla sua fruizione e circolazione (pensiamo per esempio alle foto che proprio nel mondo dei migranti vengono inviate e ricevute per dare notizie della propria condizione) –del suo ruolo nella costruzione di un’identità, le pose gerarchizzate delle foto di famiglia; sulla sua potenza evocativa e comunicativa. Vorremmo creare l’occasione per un nuovo confronto e auspichiamo naturalmente ad un rinnovato stravolgimento delle nostre aspettative.